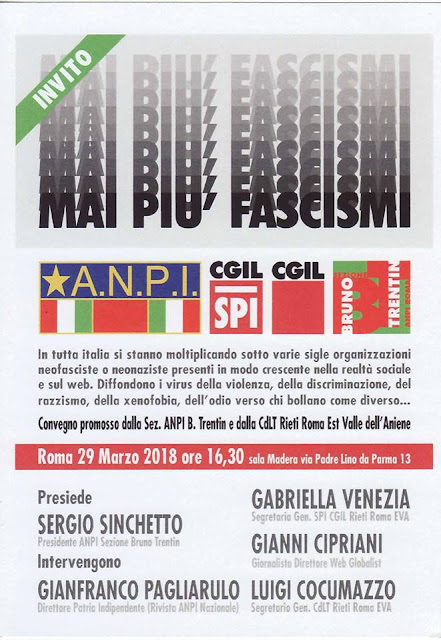O.d.g. 15 marzo 2018 dell’A.N.P.I. comitato provinciale di Roma
sul prossimo 25 aprile
Per il prossimo 25 aprile, 73° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il crimine che
costò all’umanità 60 milioni di vite, di fronte alle moderne minacce alla pace
mondiale, è necessario ricordare che la Lotta di Liberazione ha provocato la
maggiore, positiva, “rottura” di tutta l’età moderna della storia italiana, con
una strategia ed un indirizzo di fondo che venivano da lontano. La lotta di
Liberazione fu un movimento popolare, sostenuto da una grande solidarietà di
popolo, coi militari delle tre forze armate che hanno combattuto assieme per
riconquistare la libertà per tutti: per chi c’era, per chi non c’era e anche
per chi era contro, con una generosità non sempre conosciuta in altre epoche
storiche. Il ricordo di coloro che nella lotta partigiana, nei campi di
prigionia, di internamento o di sterminio, si opposero – anche sino al
sacrificio della vita – alla dittatura, alla bramosia di conquiste
territoriali, a folli ideologie di supremazia della razza, costituisce concreto
monito contro ogni tentativo di minare le fondamenta delle libere istituzioni
nate dalla Resistenza.
 |
| Targa commemorativa a Porta San Paolo |
La Resistenza non è patrimonio di
questo o quel partito, ma è patrimonio ideale e morale di tutto il popolo
italiano. La memoria non è strumento di odio o di vendetta, ma di unità di
tutti gli italiani in uno spirito di concordia senza discriminazioni, di tutti coloro
che si riconoscono nei valori di pace e di giustizia sociale proclamati dalla
Costituzione, di cui cade quest’anno il 70° anniversario dell’entrata in
vigore, scritta da quegli stessi uomini e da quelle stesse donne che guidarono
il movimento partigiano. Il 25 aprile è quindi anche il momento per una
riflessione collettiva e nazionale sulla distanza che separa ancora oggi la
nostra società, che affonda le proprie radici in quel passato terribile, da
quel disegno collettivo di un ordinamento nuovo ed antitetico al fascismo, al
nazismo e all’imperialismo giapponese, improntato a principi di pace tra le
nazioni, di libertà dalla dittatura terroristica fascista, di democrazia
parlamentare e partecipata, di affermazione della sovranità popolare e dei
diritti sociali, la cui conquista e la cui proclamazione distinsero la nuova
Repubblica da tutta la storia precedente del nostro paese. Un paese che oggi,
pur ancora tenuto insieme dai fondamenti costituzionali, soffre gravemente per
la inattuazione dei diritti sociali conquistati dalla Resistenza e dalla Guerra
di Liberazione. Pensiamo al lavoro che manca, alle paghe che non bastano, alla
insicurezza del lavoro e del posto di lavoro; alle donne ancora oggi
discriminate umiliate, offese, uccise da una cultura ed un sistema tuttora
largamente maschilista; al razzismo che va nuovamente diffondendo i propri
miasmi, fatti di falsi nemici da offrire a una popolazione sempre più impaurita
dal futuro; alla concentrazione dei mezzi di informazione e alla crisi di
rappresentanza che si esprime nella crisi dei partiti e nella perdurante alta
astensione che si registra nelle consultazioni elettorali. Il problema non è
solo italiano ma quanto meno continentale, in una Unione Europea che
privilegiando la parità dei bilanci all’urgente progresso economico e sociale
di gran parte della propria popolazione, vede riemergere dal passato formazioni
di estrema destra e a volte dichiaratamente fasciste, presenti pressoché
ovunque e non di rado in coalizioni di governo. Una Unione peraltro priva di
sistema parlamentare.
 |
| Battaglia di Porta S. Paolo del 10 settembre 1943 |
Nel 2018 cade inoltre l’80° anniversario dell’abominio delle leggi razziali, che vogliamo e dobbiamo
ricordare ponendole a monito delle future generazioni, ricordando che il
fascismo nacque fin dalle origini nella violenza che si fece istituzione con
l’orrore del Tribunale speciale, e che ad esse leggi non si arrivò
all’improvviso ma furono preparate, nella legislazione e nella coscienza degli
italiani, dalle leggi razziali adottate nelle colonie in Africa, a ricordo del
fatto che l’abominio non si produce improvvisamente, ma procede a volte da
violazioni che vengono considerate più piccole o più distanti da noi, lasciate
correre dai più, ma che portano già in esse tutto il germe della distruzione.
Il nostro pensiero va allora alla Libia, dove abbiamo visto realizzare dei veri
e propri campi di concentramento e realizzarsi alla luce del sole nuovi mercati
di schiavi, in una situazione che la coscienza del nostro paese non può
tollerare oltre.
Nel clima di crisi economica che
ancora attanaglia gran parte del nostro popolo, al quale gli ancora modesti
progressi dei conti nazionali non hanno portato alcun sollievo, ha trovato il
suo brodo di coltura un linguaggio violento e razzista che ha raggiunto il suo
apice in queste settimane con la strage di Macerata, come con l’omicidio di un
immigrato a Firenze scelto “a caso” tra la folla. Vanno rafforzandosi pericolosamente
in questo clima e in diversi territori organizzazioni politiche che fanno della
violenza e del fascismo la loro bandiera e che senza indugio devono ormai essere
sciolte. Ma c’è dell’altro. Non basta chiamare le manifestazioni fasciste col
loro nome e agire come le leggi prescrivono, soprattutto ora che questo attivismo
ha superato il limite di guardia, non basta confutare la convinzione di taluni
prefetti e questori, che rimbalza nell’opinione pubblica che riduce troppo
spesso detti fenomeni al frutto di opposti estremismi, quando la violenza
fascista ha assunto tutte le caratteristiche destabilizzanti di un tempo che si
presume irripetibile, quello dello squadrismo. Occorre chiedersi se gli
episodi, che potrebbero moltiplicarsi e dilagare, non facciano parte della
strategia politica per rendere ingovernabile il Paese, spingendolo a dotarsi di
un sistema “nuovo”, facendo del presidente del Consiglio una sorta di despota,
investito di poteri sottratti al Parlamento e al Capo dello Stato. E rifacendosi
alla storia troviamo che ritenere il fascismo un fenomeno ricorrente
politicamente trascurabile non risponde a verità. Una cosa è affermare che la
maggior parte del popolo italiano rifiuta ogni tentazione autoritaria e altra
rilevare che dalla Liberazione a oggi le trame fasciste hanno rappresentato nel
nostro Paese una costante insidia per le istituzioni democratiche. Pensiamo
allo stragismo: banche, treni, stazioni saltate in aria; ai tentativi di golpe,
alla P2; ai servizi segreti e ad un’analisi ancora in gran parte da compiere,
anche in rapporto a centrali straniere delegate ad impedire con ogni mezzo
l’avanzata delle forze popolari in Italia; pensiamo anche al fascismo come
mentalità del me ne frego. Intendendo per fascismo non solo quello del
ventennio o quello di Salò, ma ogni forma di potere autoritario, liberticida e
fortemente condizionante l’autorealizzazione della persona umana. Il fascismo è
anche rivelato da atti e comportamenti che non portano marchi di fabbrica.
Quali certe forme di razzismo esercitate verso gli emigrati o il disprezzo del
Parlamento anche da parte di esponenti politici.
 |
| Gappisti romani dopo la liberazione della città |
Paradossalmente la combinazione
della mentalità fascista, ovvero autoritaria, con la mentalità più egoistica
del liberismo, quella dei trusts finanziari impegnati oggi a fornire anche la
classe dirigente politica, con i mezzi di informazione troppo spesso asserviti
alla pubblicità e dove domina la politica spettacolo, ove i dibattiti politici
assumono maggior rilievo che nei luoghi istituzionali e sono trasformati in
intrattenimento, producono un risultato micidiale, suscettibile nel tempo a
sostituire il sistema della democrazia parlamentare con una pseudo democrazia
retta da un governo elitario, ovvero composto da tecnici e personalità che
abbiano avuto successo nella professione e nella vita, valutati per la fortuna
accumulata. Si rende allora necessaria una strategia anche istituzionale che
sia coerente alla domanda di partecipazione politica che emerge dal Paese, che
promuova l’azione fondamentale per l’autonomo e libero sviluppo e per la piena
realizzazione di ogni persona umana e che va cercando nuove forme di
aggregazione dentro e fuori i canali tradizionali, per dare attuazione e
sviluppo proprio a quei principi costituzionali coi quali possano trovare
spazio e soddisfazione le istanze di maggiore socializzazione del potere
politico generale e di maggiore e reale potere dei lavoratori e di maggiore
capacità per le stesse articolazioni elettive dello Stato, dalle Regioni agli
Enti locali; perché si sradichi dal paese la piaga della criminalità
organizzata. Sarebbe certamente azzardato sostenere che nella Resistenza fosse
chiaro in ogni sua prospettiva il disegno politico normativo dell’Italia
liberata, ma dagli atti del CLN, dalla memorialistica e dalla storiografia
emergono inconfutabili le linee guida, maturate nelle riunioni clandestine ma
anche tra i combattenti, per la formazione del nuovo Stato.
A Roma in particolare lavoriamo
perché si insista, con un corteo la mattina del 25 aprile dai luoghi simbolo
dell’inizio della Resistenza italiana, in un omaggio alla lotta partigiana
cittadina, perché venga riconosciuta finalmente, nell’intemperie dell’oggi, il
suo valore di primo piano nella Resistenza europea con il conferimento della
medaglia d’Oro al Valor Militare alla città di Roma per i fatti della
Resistenza.
Per tutti tali motivi il comitato
impegna gli organismi dirigenti a lavorare per un 25 aprile incentrato nel
riconoscere e riaffermare l’attualità del valore della Liberazione, perché ci
si ritrovi largamente per rinnovare la promessa di rispettare i sentimenti e
gli impegni che promanano dall’antifascismo e dalla Resistenza e sono
proclamati dalla Costituzione, rinnovando, con la necessaria piena attuazione
del suo dettato, l’identità nazionale che da quei fatti deriva.
Approvato all'unanimità